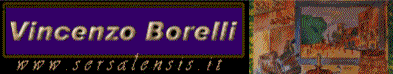 |
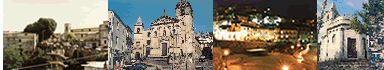 |
|
|
|
|
|
Parole & pensieri dell'Autore Taccuino Filosofia: la Tragedia Greca
La filosofia ha le sue radici nella Tragedia Greca, o meglio nel cosiddetto teatro tragico greco, pur sempre una forma d'Arte. Che cos'è la Tragedia? Il suo significato fondamentale è legato agli antichi culti religiosi della fertilità. Tragedia deriva dal termine greco Tragon-oidè che significa "canto dei caproni" un culto sacrificale. La divinità greca di questo culto dell'età arcaica era la "Potnia Theron" che significa "Signora patrona delle fiere e degli animali selvatici" - appellativo usato da Omero - ed è da identificarsi successivamente con Artemide la dea della natura rigeneratrice o della fertilità e della primavera. In epoche successive la sua figura fu associata alla dea Diana della mitologia romana, mentre nella mitologia etrusca prendeva il nome di Artume. Era la vergine dea della caccia, della selvaggina e dei boschi. Era adorata anche come dea del parto e della fertilità perché si diceva avesse aiutato la madre a partorire il fratello Apollo. Artemide era ritratta nell'arte greca dell'età arcaica come "La Potnia Theron", una dea alata che tiene in mano un cervo e un leopardo, qualche volta un leone e un leopardo. Successivamente nell'arte classica greca era spesso ritratta come vergine cacciatrice , con una gonna corta, gli stivali da caccia, la faretra con le frecce d'argento ed un arco. mentre sta scoccando una freccia, accompagnata da un cane o un cervo. In altre rappresentazioni Artemide è raffigurata anche come dea delle danze delle fanciulle, ed in questo caso tiene in mano una lira, oppure come dea della luce mentre stringe in mano due torce accese e fiammeggianti. Col passar del tempo questo culto viene inserito nel culto di Dionisio il dio della vita vista come contraddizione e come lotta: da ciò parte la concezzione di filosofia. L'esistenza umana incomincia ad essere vista come contrasto e contraddizzione. Da ora in poi i filosofi cercano il nesso tra questi contrasti e contraddizioni, cercheranno di spiegare i perché, cercheranno di farli convivere insieme. Teatro. Col passar del tempo da un contesto culturale e religioso la tragedia passa in teatro, diventa rappresentazione teatrale. Il teatro tragico greco da forma con rappresentazioni a quella che è la concezzione della vita. L'essenza della tragedia sono il dilemma e la peripezia. Questa tragedia si esprime con sei elementi base che sono:
La tragedia è vista come un'azione in cui il protagonista si trova in una situazione ambigua in cui egli domina il dramma e nello stesso tempo non domina, da un lato governa e dall'altro è tenuto in scacco da essa. Il personaggio tragico è colpevole ed insieme innocente. In una parola monta un gioco in cui è giocato lui stesso. Nella tragedia il reale, il vero emerge sempre come enigma. La tragedia simbolizza il doppio volto del reale; la tragedia è vista come esperienza crudele dell'esistenza, esperienza del dolore. Tutto questo i greci antichi lo chiamavano "destino" o "Fato". Gli stessi dei del quale si invoca la protezione non sono una protezione sicura, le vie che indicano da seguire a volte divengono un vicolo ceco. La tragedia pone davanti agli occhi dello spettatore questioni teologiche (da non intendere in senso biblico e cristiano) e morali e quindi, lo costringe ad un giudizio sul bene e sul male, a dare un senso alla realtà presentata a decidere dei valori e sui valori. Con questi valori la tragedia del teatro greco si trasforma in teatro filosofico. Il dilemma che pone la tragedia è indicata da questa argomentazione:
____________________________________ Fertilità. Già dal principio l'uomo si domandava sulle proprie origini e per esteso dell'universo intero: da dove veniamo e dove siamo diretti, qual'è lo scopo della vita, dell'esistenza, dell'universo. Tragon-oidè. Tragodia (tragedia) è l'equivalente di Tragon-oidè (tragon o tragos= capro. Oidè= canto). Secondo il Dizionario Illustrato Greco-Italiano di H. G. Liddell e R. Scott, 1975 ed. Le Monnier, pag. 1292, tragedia è la "rappresentazione che, in origine, presso i Dori aveva probabilmente carattere lirico; ad Atene assunse forma drammatica, ... . Il significato proprio della parola è <<canto del capro>>, o perché originariamente era in palio un capro come premio, o perché i cantori erano travestiti da satiri." Dionisio: chiamato anche Bacco, era figlio di Zeus il dio più potente del monte Olimpo residenza degli dei, e di Semele, una donna di origine umana. Dio del vino, della gioia e del delirio mistico, montava un carro tirato da pantere e ornato di edera e di pampini scortato da un corteo di Baccanti donne, Sileni e Satiri che lo seguivano ovunque egli andava. Dionisio era venerato con culti tumultuosi e orgiastici, nei quali erano rappresentati con mashere i geni della terra e della fecondità. In queste cerimonie, chiamate Baccanali, era fatto largo uso del vino, ci si abbandonava ad ogni forma di depravazione, dissolutezza e volgarità in cui era ammessa la partecipazione di tutti, uomini e donne, giovani e vecchi, in preda a un'euforica ebbrezza. -Gabriella D'Anna, Dizionario dei Miti, prima ediz. marzo 1996, Tascabili Economici Newton- Teatro. In origine i poeti erano "cantori" che recitavano, (tragodos= cantore del capro, cioè poeta e cantore tragico) in seguito, quando i poeti cessarono di recitare, il termine cantore significò "attore tragico" mentre il poeta tragico fu chiamato diversamente. Quindi, in origine la filosofia nasce in simbiosi tra fede, culto, religione e teatro, poesia, quindi oggi diremo ARTE. Oreste: figlio di Agamennone e Clitennestra, fratello di Ifigenia e di Elettra, ancora bambino è presente in Aulide nel momento in cui la sorella Ifigenia veniva offerta in sacrificio alla dea Artemide. Dopo l'assassinio del padre fu salvato dalla sorella Elettra, che lo mandò presso il re Strofio, il quale lo allevò insieme a suo figlio Pilade, che diverrà il suo grande amico. Divenuto adulto andò con Pilade a Micene, per vendicare l'assassinio del padre e uccise Egisto e Clitennestra, ma ben presto impazzì e fu perseguitato dalle Erinni per il suo matricidio. Giuunse ad Atene, dove sotto la protezione della dea Atena fu giudicato dall'Areopago, che lo assolse. Oreste si recò poi nella Tauride, dove Toanto, re del luogo, sacrificava tutti quelli che riusciva a catturare. Egli doveva essere sacrificato ad Artemide, ma la sacerdotessa della dea era Ifigenia sua sorella, che avendolo riconosciuto, non solo lo salvò ma fuggì con lui. Poi andò a Micene, dove prese moglie sposando Ermione, figlia di Menelao, alla quale suo padre lo aveva fidanzato quando era ancora bambino, e da lei ebbe un figlio, Tisamene. Nelle opere dei tragici tutte queste vicende sono diversificate e arricchite di particolari diversi, in cui egli diviene anche un eroe di primo piano. -Gabriella D'Anna, Dizionario dei Miti, prima ediz. marzo 1996, Tascabili Economici Newton-
|
|
© Tutti i diritti riservati 2004
www.sersalensis.it - infoClick->Mewebmaster:
info@sersalensis.it





